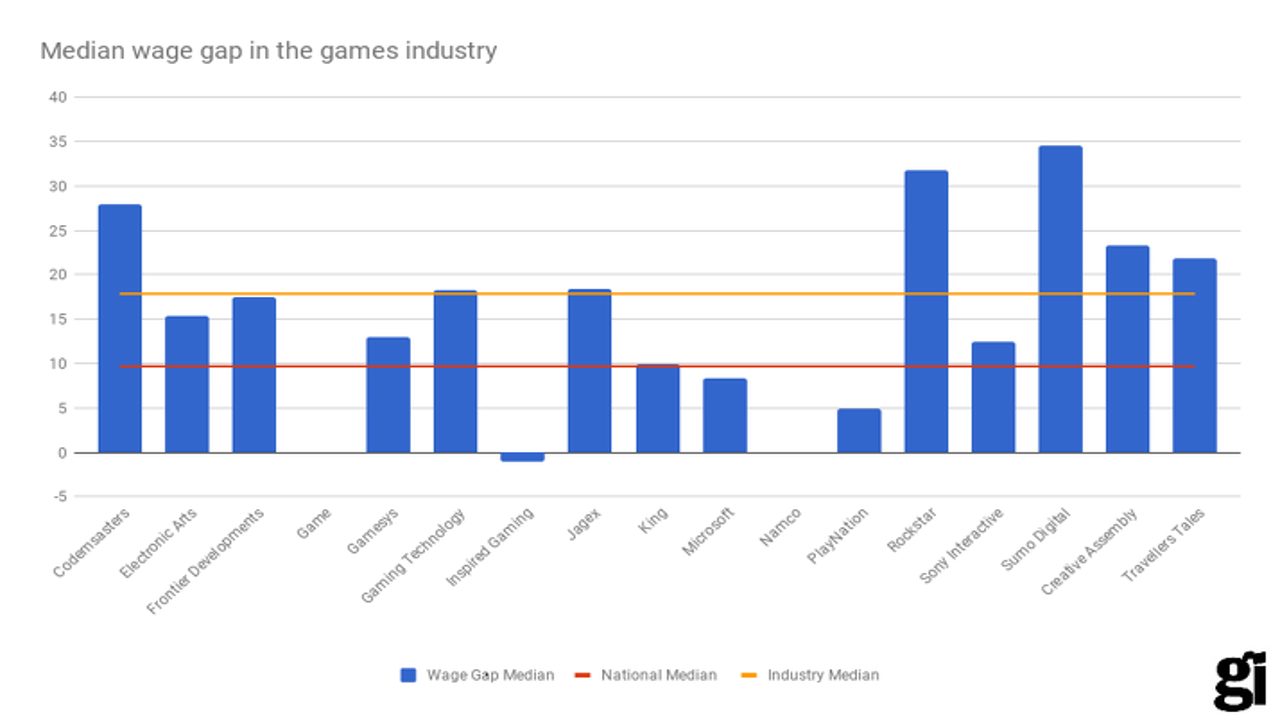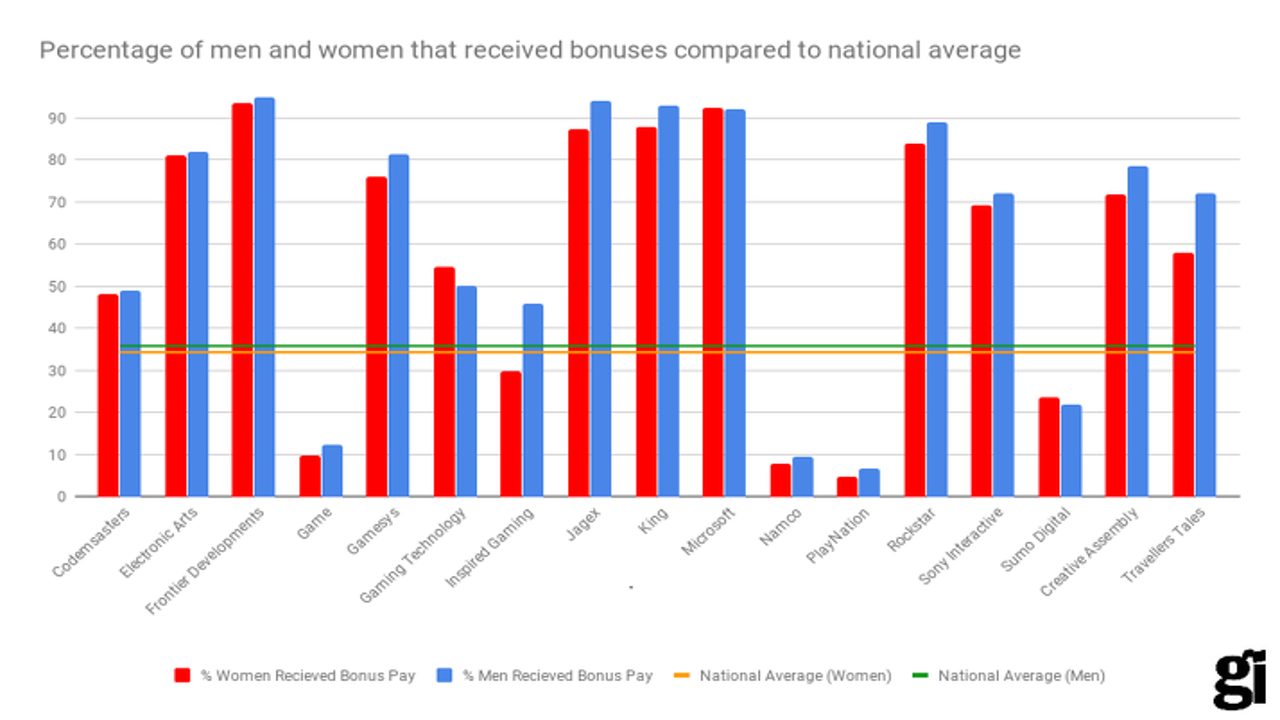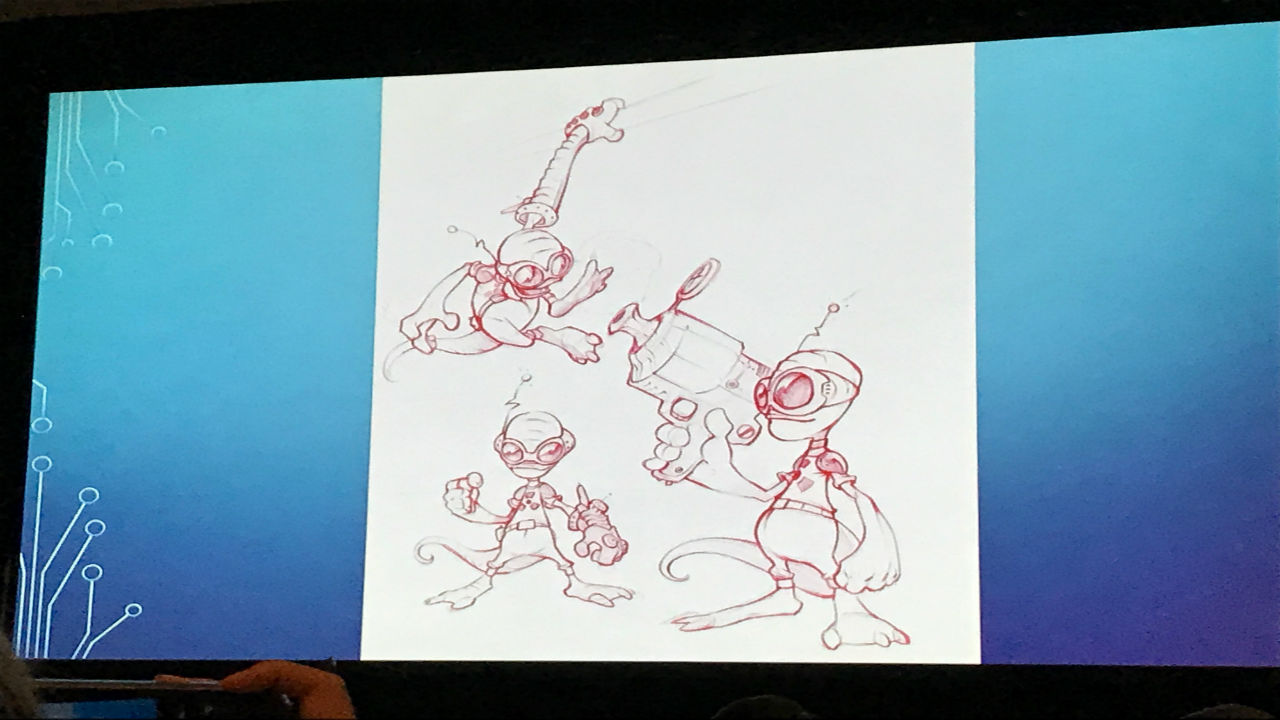Sono trascorse un paio di settimane dalla GDC (Game Developers Conference), quando il team Insomniac, salì sul palco per parlare dei 15 anni di storia, di una delle loro IP più conosciute: Ratchet & Clank. Ma gli interventi dello stesso team di sviluppo, sono stati tutt’altro che celebrativi per quanto riguarda la famosa saga.
Il regista Brian Allgier dice:
«Protagonista del gioco, in principio, sarebbe dovuto essere una ragazza con un bastone, una sorta di mash-up tra Zelda e Tomb Raider, ma quest’idea purtroppo non era ben vista dal team, che avrebbe dovuto lavorare poi sul gioco. A quel punto Ted Price (Presidente di Insomniac) decise di troncare quel concept che era stato intitolato appunto “Ragazza col bastone”. Era il 2001, Insomniac aveva 35 dipendenti che stavano lavorando al progetto e avevano bisogno di una nuova idea vincente. Il capo-ufficiale creativo, Brian Hasting, annotò una frase molto generica sulla lavagna degli appunti “un alieno, che gira tra i pianeti raccogliendo armi e gadget”, il team accolse positivamente da subito la nuova proposta, era un idea semplice ma aveva funzionato.»
Dopo aver cestinato un paio di concept, il team riesce a concretizzare finalmente i primi progetti di Ratchet, soprannominato “Lombax” da Ted Price, e del suo aiutante Clank. Inizialmente la squadra aveva pensato di metterne uno a capo dell’altro ma poi optarono per porli allo stesso livello. L’intenzione sin da subito, fù quella di creare qualcosa che fosse un mix tra il poliziesco Arma Letale e i cartoni animati del sabato mattina.
Durante la stesura del prototipo, il team non riuscì a far sì che la tecnologia PS2 iniziale gestisse correttamente il gioco, per questo motivo quindi lavorò fianco a fianco con Mark Cerny per ottimizzare la tecnologia della console Sony, che una volta migliorata, permise finalmente a Ratchet & Clank di vedere la luce.
«Il primo gioco era innovativo e fatto bene – dice insomniac alla GDC – Ma era più un gioco di ruolo e le armi sembravano quasi opzionali. I due personaggi Ratchet e Clank non avevano moltà profondità, anche Ratchet stesso risultava essere borioso, sarcastico e non eccessivamente simpatico».
Insomniac, decise di concentrarsi sul contorno, personaggi, armi e humor, a partire dal secondo capitolo, Fuoco a Volontà (2003). Quando successivamente arrivò anche il terzo, Up your arsenal (2004), fu un vero e proprio successo per il franchise. Finalmente Ratchet & Clank aveva una propria personalità ben definita: era un gioco in perfetto equilibrio tra un platform e uno shooter, che raccontava una vera storia d’amicizia, con un contorno di armi fantasiose e gadget intelligenti, arricchito dalla possibilità di esplorare i pianeti. Un gioco pieno di colori vivaci e umorismo.
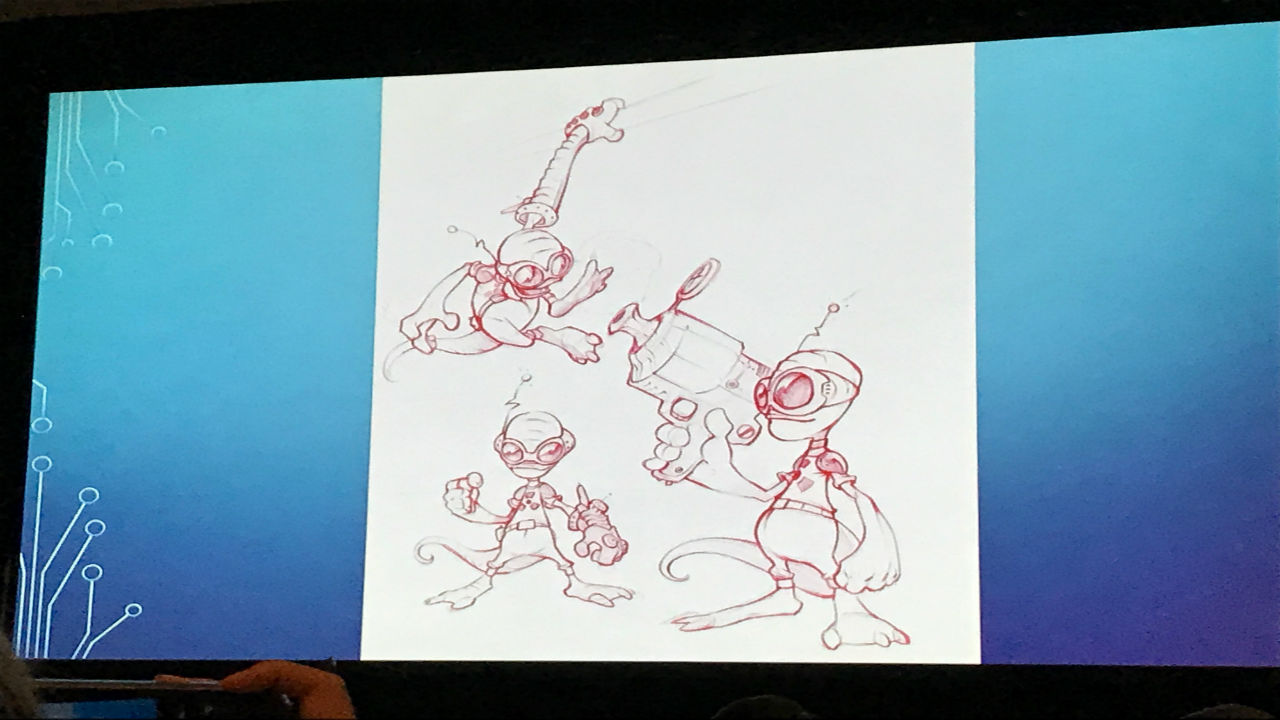
Nel corso del GDC, Insomniac ha voluto sottolineare solamente dove e perché, il team ha deluso le aspettative dei propri fan. Dal terzo capitolo in poi, lo studio aveva evoluto con successo la serie da un “platform con un carattere da sparatutto”, a uno “sparatutto con un carattere da platform”.
Eppure, nonostante tutto, Insomniac stava iniziando a preoccuparsi sempre di più che i giorni del “personaggio mascotte” stavano per finire. Sentiva che era necessario cambiare qualcosa per mantenere la serie sull’onda del successo, il tutto racchiuso nelle parole di Brian Allgeier:.
«Adattati o muori, ascolta ciò che i giocatori vogliono, osserva le tendenze e amplifica ciò che contraddistingue il tuo gioco».
Lo studio sentiva di aver raggiunto il vero successo con Up Your Arsenal, ma la filosofia “adattati o muori” applicata da quel momento, avrebbe inevitabilmente portato a un “crollo”. Per evitare che il franchise stancasse i fan infatti, il team di Insomniac, ispirato dalla serie Halo, produsse, nel 2005 sempre per PS2, Ratchet: Deadlocked (conosciuto anche come Gladiator). Era stato rimosso Clank dal nome («non è stato bello», ammette lo studio, che era pesantemente combattuto) e il gioco non includeva il popolare Qwark. Insomma, il titolo non aveva più tutte quelle caratteristiche che avevano reso un successo Ratchet & Clank e il risultato fu infatti, che ai fan non piacque, tanto che sia Allgeier che TJ Fixman (lo scrittore della serie), ammisero di aver commesso un grande errore allontanandosi da quella che era l’idea originale della serie, nello sviluppo di questa nuova veste di gioco non proprio azzeccata.
Insomniac, a quel punto, sapeva che in futuro avrebbe dovuto attenersi il più possibile al DNA del gioco originale, cosa che fece quando nel 2007, sviluppò il quinto capitolo della serie: Ratchet & Clank: Armi di Distruzione, sui sistemi PS3. Fu una sfida ardua per il team, quella di effettuare un restyling completo passando da una generazione a un’altra, ma alla fine riuscì nel proprio intento, creando nuovamente quello che era per i fan il vero Ratchet & Clank di un tempo, ma questa volta con una veste del tutto rinnovata. Praticamente un successo, o quasi, poiché a molti fan non piacque il finale, che vide Clank rapito dal misterioso Zoni. Così il team decise di dare qualcosa ai giocatori per rimediare, sviluppando un anno dopo un breve DLC, chiamato Alla ricerca del tesoro, che mise una pezza al buco creato dalla precedente storia, introducendo anche diverse novità al gioco, come i dialoghi, i puzzle-game e altro.

Proprio perché non era un vero e proprio capitolo di Ratchet & Clank, Alla Ricerca del Tesoro, permise al team di osare sotto alcuni punti di vista tecnici, ma anche di dare un filo logico a quello che poi sarebbe stato il successivo, e ultimo capitolo, della serie, che arrivò poi nel 2009 con A Spasso nel Tempo: un successo indiscusso sotto ogni punto di vista che vide, nel finale, anche l’annientamento del super-cattivo Nefarious in una delle basi spaziali.
L’epilogo della serie andò talmente bene che Sony pretese da Insomniac che si rimettesse a lavoro su un ulteriore capitolo della serie. Inizialmente cercarono di evitare questa forzatura narrativa che aveva visto il suo capolinea nell’ultimo gioco, ma alla fine i fan e Sony ebbero la meglio, convincendo Insomniac a rimettersi in carreggiata e pubblicare nel 2011, Ratchet & Clank: Tutti per Uno, che costrinse anche TJ Fixman a modificare il finale della serie trovando un modo per non far sfuggire Nefarious al suo destino che sembrava essere stato già designato, e che, per volere di Sony, doveva essere presente nel nuovo titolo. Alla fine, Tutti per Uno risultò essere uno dei migliori spin-off della serie, ma purtroppo non ebbe il successo sperato. Successo che arrivò invece due anni dopo, nel 2013, con Nexus, ultimo capitolo della serie, una storia breve ma ben sviluppata.
Da quel momento Insomniac e Sony avevano deciso di comune accordo di mettere da parte il franchise.
Almeno finché, nel 2016, non venne nuovamente tirato fuori da Kevin Munroe e Jericca Cleland che diressero per il grande schermo, Ratchet & Clank: film d’animazione basato sul gioco, ma che si allontanò troppo dalla mitologia originale dell’IP per l’adattamento cinematografico.
Allgeier decise così di sfruttare la corrente e creare al contempo anche un nuovo titolo, per PS4 questa volta: «Un gioco basato sul film basato sul gioco», dice scherzando. Proprio per aggirare il problema creatosi con il filo narrativo della pellicola cinematografica, TJ Fixman decise di affidare la narrazione a un personaggio improbabile e poco raccomandabile, il capitano Qwark, giustificando così alcune eventuali incongruenze narrative.
Il remake di Ratchet & Clank fù un vero e proprio successo, con numeri che non si vedevano dai tempi dei vecchi titoli su PS2.
Allgeier conclude:
«Dove la serie andrà a parare in futuro non è certo, ma una cosa lo è, “adattarsi o morire” è una opzione, ma allontanarsi da quello che è il DNA del gioco, è un errore. Abbiamo imparato tutto ciò che potevamo sulla chiave del successo di Ratchet & Clank, lo abbiamo migliorato e aggiornato. Adesso ci spingeremo verso l’ignoto!».