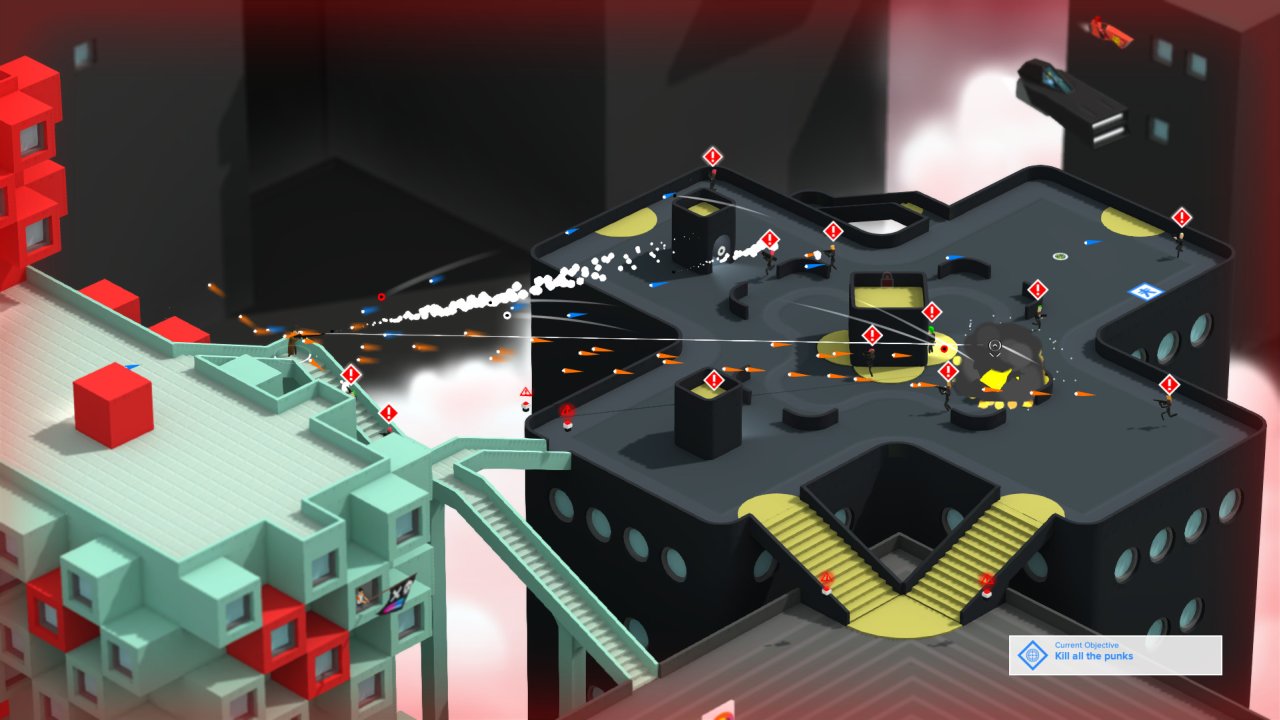Detroit: Become Human
Mi ci sono volute due run prima di decidermi a parlare dell’ultima opera di David Cage. Nel momento in cui scrivo questa recensione, a quattro mesi di distanza dall’uscita del titolo, mi sembrano ancora poche. Detroit: Become Human non condensa soltanto un messaggio profondo, a più livelli, in un videogame ben congegnato, ma esprime soprattutto un potenziale narrativo ben sviluppato in un articolato dell’albero delle scelte, dando vita a una narrazione che è forse la più equilibrata e densa fra quelle sfornate da Quantic Dream in tutti questi anni di development.
Gli androidi sognano (non soltanto pecore elettriche)
Come nel precedente Heavy Rain, Detroit: Become Human segue la storia di più personaggi, tre nel caso in questione: Kara (Valorie Curry), in fuga per salvare la piccola Alice (Audrey Boustani) da un padre violento, Markus (Jesse Williams) che si ritrova suo malgrado dalle ceneri della distruzione alla testa di una rivolta, e Connor (Bryan Dechart), androide progettato per supportare il tenente Hank Anderson (Clancy Brown) nelle indagini che vedono coinvolti i “devianti”. Tre storie separate che si incroceranno nella Detroit del 2038, in un futuro che non possiamo definire né distopico, né esattamente ucronico, e che David Cage e il lead writer Adam Williams tentano di raccontare nella forma della fantascienza autoriale, sulla falsariga dei grandi narratori del genere. Non staremo qui a perderci in parallelismi con Gibson, Asimov, Lem, Dick, Le Guin e in tutta la letteratura di riferimento che permea quest’opera, né analizzeremo i punti in cui Detroit: Become Human falla o regge dinanzi ai suoi omologhi letterari (a cui vanno aggiunti quelli cinematografici), sarebbe un’operazione lunga e inappropriata, a un approfondimento simile va riservata altra sede.
A favore della relativa brevità di cui una recensione si avvantaggia rispetto a un testo critico, ritorniamo al contesto di riferimento: i tre personaggi giocabili di questa storia si troveranno ad affrontare il divenire delle loro storie in un momento cruciale per la storia umana. Creati dal genio di Elijah Kamski (Neil Newborn), gli androidi sono ormai una realtà consolidata da anni: prodotti e immessi sul mercato dal colosso Cyberlife, sono diventati un elemento fondamentale nella vita di ogni cittadino americano, il quale è libero di utilizzarli a piacimento, dalle pulizie di casa al piacere sessuale. Gli androidi sono macchine senzienti ed evolute, hanno sviluppato una forma di coscienza, la loro intelligenza artificiale gli permette di prendere decisioni autonome, pur restando nei limiti comportamentali imposti dal software. Ma adesso in città si registrano sempre maggiori casi di “devianti”, androidi che sfuggono alle regole imposte dal loro codice e che adesso si rivoltano contro gli umani. Per ragioni profondamente diverse, Markus e Kara si ritrovano a “reagire”, a divergere dall’algoritmo, e per questo diventano devianti. Connor corre nella direzione opposta: stabile, ligio ai doveri del software, l’agente modello RK800 avrà il compito di indagare per riportare l’ordine sconquassato dal dilagare della devianza androide.
Ecce Robot
In Detroit: Become Human gli androidi ci appaiono umani in tutto e per tutto: come ne Il Cacciatore di Androidi di Dick in qualche opera (non tutte) di Isaac Asimov, sarebbero indistinguibili dai cittadini di Detroit se non fosse per un chip luminoso applicato circolarmente alla loro tempia destra. Fin dall’inizio, gli androidi ci vengono presentati come incapaci di emozioni, ma ci si rende conto ben presto (controllando i protagonisti) che non è affatto così, e cominciamo a presagirlo nelle prime scelte multiple possibili, dove si vedono barlumi di sentimento già sin dalle fasi iniziali. Quasi non stupisce che Kara e Markus rompano la barriera delle regole imposte dall’algoritmo per proteggere persone a loro care, seguendo un sentimento di giustizia che si annida probabilmente negli abissi della loro coscienza. Una coscienza che mostrano di avere in una serie di frangenti, ed è qui che si trova uno dei punti fermi dell’opera: i finali possibili sono tantissimi, e dipendono tutti da una combinazione di scelte precedenti. Il destino di un personaggio può cambiare radicalmente, si può vivere o morire, mettersi in salvo o essere catturati, ribellarsi o fuggire, ma c’è un aspetto che sembra non essere in discussione: anche gli androidi sono capaci di sentimenti. Da qui una delle domande fondamentali del gioco: è giusto ridurre in schiavitù degli esseri senzienti, capaci di soffrire e gioire? È giusto soggiogare il loro libero arbitrio ai bisogni umani? Il creatore ha diritto di proprietà, nonché di vita e di morte, sulle proprie creature? Non sembra porsi qui nemmeno il discorso della pericolosità a priori degli androidi: i robot non hanno qui manie di grandezza o di conquista del potere, né sono macchine assetate di sangue, vogliono solo la libertà, anche la loro violenza è di reazione più che d’ambizione. Markus può diventare in qualche modo uno Spartacus dei tempi futuri, è un mondo in cui fra gli androidi circola il nome di una figura messianica, Ra9, sussurrata in segreto o scritta in muri nascosti, la cui parola è passata di soppiatto come fosse un samizdat.
Il discorso va ancora più in profondità, facendosi metafora del nostro tempo quando si parla di discriminazione: gli androidi sono una minoranza, vittime del volere della razza dominante, quella umana. Fino a che punto è diverso, oggi, il discorso etnico?
Markus è un androide di colore, una minoranza nella minoranza in una società composta di umani prettamente di etnia caucasica, e non è un caso che il suo finisca per essere un ruolo chiave in prospettiva di una rivolta androide. Qualunque sia la strada verso la quale lo guideremo (che non necessariamente lo porterà sulla via della rivoluzione), certamente arriveremo a Jericho, la misteriosa destinazione verso la quale si dirige ogni androide in cerca di un luogo sicuro. Per farlo, passeremo attraverso gli indizi nascosti in vari murales, lasciati lì per indirizzare sulla giusta strada come i sassolini di Hansel e Gretel.
Non è un caso che uno dei graffiti abbia al centro Cassius Marcellus Clay, che nel 1965 cambiò il proprio nome in Muhammad Alì a seguito della propria conversione all’Islam e che anni dopo, nel 1968, si oppose alla guerra del Vietnam affermando di non aver nulla contro i Vietcong, i quali, a differenza di vari suoi concittadini americani, non lo avevano “mai chiamato nigger”. Nello stesso murale, sulla parte destra, si trova inoltre un leone, probabile riferimento a Zion, utopica terra promessa mutuata dall’ebraica Sion e opposta all’oppressiva “Babylon” del mondo moderno. Il concetto è alla base del Kebra Nagast, testo sacro del rastafarianesimo, che racconta, fra le altre cose, del passaggio dell’Arca dell’Allenza da Gerusalemme all’Etiopia, la culla dell’umanità, che non a caso aveva come simbolo il Leone di Giuda nella propria bandiera.
Markus è dunque un probabile simbolo della lotta contro la discriminazione etnica, così come la storia di Kara potrebbe esserlo contro la violenza sulle donne e sui minori: l’androide donna AX400 viene riportata a casa dal padre di Alice, Todd, che l’aveva già precedentemente distrutta e portata a riparare. Il viaggio della ragazza e della ragazzina ha un valore filiale, che vedrà la più adulta rischiare il tutto per tutto per portare in salvo la piccola, dritte fino in Canada, dove gli androidi non sono oggetti immessi sul mercato e godono degli stessi diritti degli umani, e che come in The Handmaid’s Tale diventa una meta a cui aspirare, una terra promessa di uguaglianza e libertà.
Visioni di robot
La storia di Detroit: Become Human è dunque ricca sul piano simbolico, oltre a risultare ben scritta. I dialoghi sono solidi, la narrazione dinamica e dal buon ritmo, e soprattutto mancano i plot hole che gravavano su alcuni precedenti titoli, rei di aver drasticamente allontanato storie come quella di Heavy Rain dall’eccellenza.
Il lavoro scrittoriale di Cage e Williams non gode di elementi particolarmente stupefacenti, ma la storia ha un indiscusso equilibrio e risulta di certo il punto più alto della produzione Quantic Dream, come lo è tutto il comparto tecnico. Se su PS4 l’immagine di Detroit: Become Human gode di una risoluzione di 1080p, su PS4 Pro raggiunge i 2160p tramite il checkerboard rendering, con un anti-aliasing temporale atto a eliminare effetti edge shimmer e aliasing sulle superfici. Il gioco si mantiene a 30 fps costanti, con alcuni cali negli spazi aperti dove è possibile apprezzare la maggior potenza di PS4 Pro nell’evitarli, e dove, in generale, il clustered forward rendering torna molto utile in termini di illuminazione, con uno straordinario risultato ottenuto tramite un mix di luci dinamiche che accentua il realismo. Come rilevato anche da Digital Foundry, il lavoro di Quantic Dream sui materiali e sul loro rendering basato sulla fisica è mirabile, gli oggetti sono impreziositi dalle loro stesse imperfezioni, la BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) restituisce un risultato che accentua il senso del reale nel rapporto tra luci e materia. Sempre a proposito di renderizzazione, uno dei punti più alti di questo lavoro è stato fatto sui personaggi, con modelli che risultano vividi e realistici anche nei primissimi piani, dove risaltano sguardi di grande intensità e una resa della pelle straordinaria, valorizzata da uno scattering subepidermico che valorizza il rapporto tra luce e pelle, restituendo un realismo fra i più belli mai visti.
Realismo globalmente accentuato da tutto il lavoro fatto nel comparto audio, con una gamma di suoni amplissima negli scenari più disparati, apprezzabile nel livello di dettaglio raggiunto negli spazi aperti, dove la gamma di suoni ambientali riprodotta riesce a comporre un quadro già ben ricostruito sul piano visivo, e dove anche il suono della monorotaia in centro città ha una sua personalissima voce. La soundtrack diventa così un elemento atto a impreziosire un lavoro di altissima fattura, con ben tre composer impegnati a dar la musica alle circa 10 ore di gioco del titolo: ogni musicista è stato infatti impegnato a musicare la diversa storia di un personaggio, da Philip Sheppard, che ha dato vita a un emozionante lavoro di violoncello per la storyline di Kara, all’iraniano Nima Fakhrara, che ha regalato musiche d’ispirazione altamente cinematografica per Connor, fino a John Paesano, che ha puntato sull’epicità crescente per raccontare la storia di Markus, in un climax armonico di altissimo livello in cui la musica è colonna portante della grammatica emozionale del titolo. Tutte e tre i compositori tengono conto di con influenze brass, funk e blues, quasi come dovuto omaggio a Detroit, città che ha dato i natali alla storica casa discografica Motown.
Diagrammi di flusso
Il lavoro globale di Detroit: Become Human consta di un felice mix di ricostruzione e invenzione: l’intera città di Detroit è stata ricostruita partendo dalla reale città, con un’accurata ricostruzione di luoghi come Capital Plaza, e anche la folla ha un alto livello di realismo, non essendo generata proceduralmente ma riprodotta tramite attori. Sono stati necessari circa 2 anni e mezzo per registrare le scene racchiuse in circa 3000 pagine di sceneggiatura: basta pensare che Beyond: Two Souls ha richiesto solo 9 mesi per comprendere la differenza di portata del lavoro di Cage, che con il suo team di designer ha messo su un impianto in cui il rapporto tra game e narrative design è strettissimo ed efficace, e dove la scelta dei percorsi risulta ogni volta abbastanza chiara all’interattore, che capirà ben presto come al tasto triangolo corrisponda una risposta fredda, mentre al cerchio corrisponde di solito un maggior coinvolgimento emotivo. Dalle risposte e dalle scelte dipenderà l’evolversi della storia, e quindi della storyline di ogni personaggio. L’engine proprietario sul quale è costruito il gioco, il Buildozer, ha permesso a Quantic Dream di gestire una ramificazione estremamente complessa di una narrazione basata su visual scripting e real time editing (rendendo il gioco completamente WYSIWYG). La flowchart delle scelte sia visibile al giocatore/interattore alla fine di ogni scena (permettendo anche di visionare nelle successive run le scelte prese in precedenza), ma lo scorso mese lo stesso David Cage ha offerto uno sguardo su Twitter di quella che è la struttura delle scene del gioco Quantic Dream:
Ever wondered what the structure of a scene by Quantic looks like? Here are two charts showing what a nightmare our games are to write, script, shoot and test… but this is also what makes them special!
Props to our scripters 😉#DetroitBecomeHuman#ConnorArmypic.twitter.com/LgR4yLH4db— David Cage (@David__Cage) 28 agosto 2018
We are the Robots
Rilasciato nel maggio 2018, il gioco ha raggiunto a 3 mesi dall’uscita 1.5 milioni di giocatori, il miglior risultato di sempre per la casa transalpina. Detroit: Become Human ha dato sostanza al timore umano che le macchine possano sostituirsi a ognuno di noi, e nel gioco c’è tutto questo: non soltanto dunque un quesito sull’intelligenza artificiale, il suo sviluppo e le sue implicazioni, ma anche il tema del global warming, del rapporto fra uomo e ambiente, e altre tematiche che emergono dai dialoghi ma soprattutto dai vari magazine (Detroit Today, Century, Gossip Weekly, Tech Addict, All Sports, Green Earth) che troveremo sparsi per i vari scenari, contenenti veri e propri articoli atti a darci un quadro completo dello zeitgeist imperante. Fra i temi caldi emerge anche quello del rapporto tra minoranza e discriminazione che abbiamo già citato, e che risulta centrale già dal titolo dell’opera, che richiama chiaramente con lo “Stay Human” coniato da Vittorio Arrigoni e messo ogni volta al termine dei suoi. C’è spessore politico e sociale, ma anche scientifico, con un’indagine non rivoluzionaria ma neanche blanda su problemi etici e gnoseologici come anche sull’evoluzione tecnologica futura, svolta con una certa assennatezza, come ha sottolineato Envisioning in una ricerca corredata di un’interessante infografica interattiva, dove vengono analizzati gli aspetti del gioco legati all’evoluzione scientifica .
Siamo insomma davanti al miglior prodotto di sempre di Quantic Dream, che unisce una narrativa pregevole a un game design ben studiato che non abbandona l’approccio cinematografico dei precedenti lavori di David Cage, impreziosito da un comparto audiovisivo di altissimo livello. I difetti si ravvisano soprattutto nella parte finale, e solo in termini di coesione narrativa, ma non ci sono più le voragini o gli inciampi dei precedenti titoli. Abbiamo davanti un ottimo lavoro di interactive storytelling. E speriamo che la parabola, da adesso, sia solo ascendente.