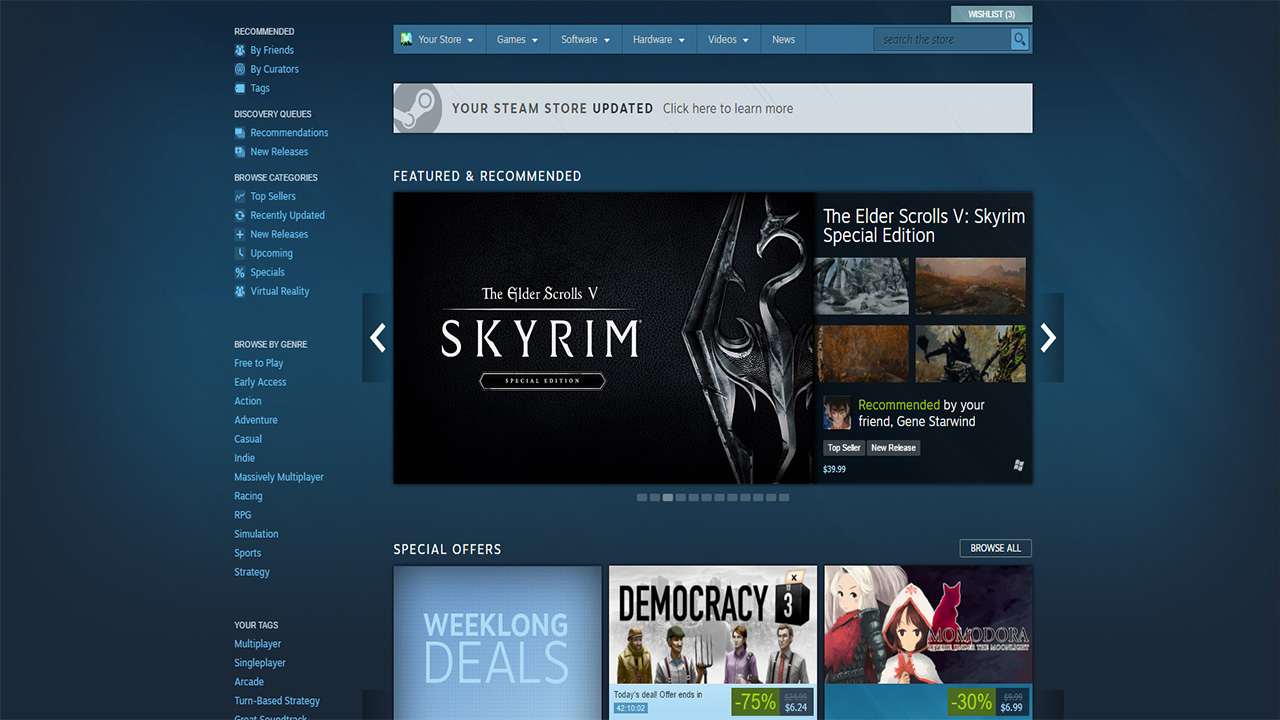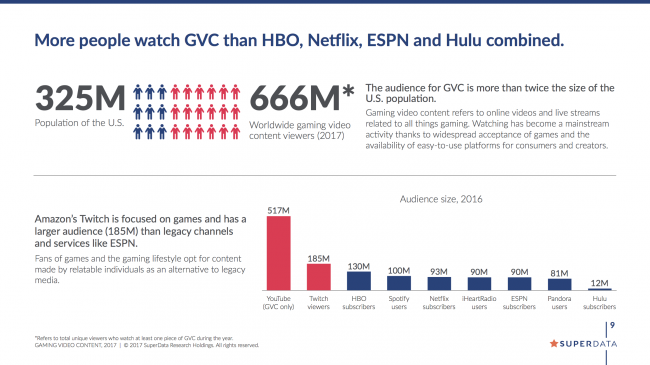Il Re Leone – Ovvero come ho imparato a preoccuparmi e a odiare la bomba
La nostra è un’epoca strana, stretta in un limbo che vede agli opposti un futuro radioso/deprimente e un passato che non smette mai di essere migliore di quanto effettivamente sia stato. E con il cinema (o cinematografò se preferite) la storia non cambia: Star Wars, Ghostbusters, Il Pianeta delle Scimmie, Star Trek, Total Recall, Alien e chi più ne ha più ne metta, hanno visto negli ultimi anni nuove trasposizioni più o meno riuscite e tra queste, non poteva mancare mamma Disney. Negli ultimi anni la moda della riproposizione dei “classici” in salsa live action è letteralmente esplosa – la bomba, nel titolo – con risultati a volte sorprendenti: Cenerentola di Kenneth Branagh riesce effettivamente ad avere una sua identità, approfondendo una struttura narrativa che per forza di cose mancava nell’originale, impreziosito da scelte stilistiche che ne hanno risaltato il tutto. A modo loro, anche Il Libro della Giungla, La Bella e La Bestia, Dumbo e così via sono film che godono di propria linfa vitale, dando un contenuto in più non solo a chi è amante dei cartoni animati ma anche a chi di Disney interessa il giusto. Tutto questo con alti e bassi, sia ben chiaro, ma l’intento – anzi l’impegno – di andare al di là di quanto visto finora è sotto gli occhi di tutti.
E poi arriva Il Re Leone.
Un capolavoro senza tempo (appunto)

Per quelle due, tre persone che non hanno mai sentito parlare del Re Leone, oltre ad aspettarvi un destino simile a Cersei Lannister a suon di “Vergogna!”, tocca recuperarlo. È uno dei pochi casi in cui non c’è opinione che tenga, in quanto, il film animato del 1994 risulta essere ancora oggi uno dei migliori lungometraggi di genere della storia del cinema. E il perché è presto detto: il primo classico Disney a vantare una storia originale, attinge sì dai classici stilemi narrativi di genere, costruendo una trama a tratti “shakespeariana” e capace di maneggiare con cura gli elementi più importanti che hanno caratterizzato la narrazione sin dalla notte dei tempi. Amore, odio, vendetta, redenzione, rinascita, consapevolezza sono tutte racchiuse nel personaggio di Simba che durante il suo percorso, ritrova se stesso accettando il proprio destino. Nonostante il contesto e il target di riferimento, Il Re Leone è qualcosa che viene apprezzato soprattutto “da grandi”: il viaggio di Simba è soprattutto interiore e facilmente empatizzato dalla maggior parte degli spettatori. La fuga con successiva “zona di comfort” sono elementi che vanno al di là del semplice Hakuna Matata di Timon e Pumba, una filosofia (concentrarsi sul presente evitando che passato e futuro influiscano negativamente) che è solo l’anticamera di quanto vediamo a schermo. Simba fa suo l’Hakuna Matata, ma va oltre. Il passato per quanto doloroso va accettato e anche l’influenza negativa che può aver sul presente può essere usato come leva per realizzare esperienze migliori, non solo per sé ma per tutto il regno. Evitando di dilungarci ulteriormente, l’originale Re Leone è qualcosa di estremamente attuale e lo sarà probabilmente sino alla nostra estinzione. Questo perché essenzialmente Il Re Leone, parla di noi, di ciò che siamo e di quello che potremmo essere se solo ci conoscessimo un po’ meglio.
Tutto molto bello, tutti molto felici, sino a quando anche qui la mano a forma di dollaro non ha deciso di afferrare per la coda il povero Mufasa.
I bambini – oltre a essere gli esseri più malvagi dell’Universo – sono anche attenti al mondo che li circonda e ovviamente, il digitale ha preso il sopravvento; come naturale che sia, l’attrattiva dei bambini è virata su qualcosa di molto simile a un videogioco. Nulla di male, per carità; abbiamo avuto titoli degni nota come Coco (disponibile finalmente su Netflix), Up, Inside Out ma anche quel Spiderman – Un Nuovo Universo che riesce anche a elevare il genere. Se gli ultimi live action possono aver effettivamente un senso, vantando tra le fila anche un cast umano, ne Il Re Leone tutto questo prende una piega inaspettata e a tratti deludente.
Uno Specchio Oscuro

Partiamo da una premessa: l’emotività scaturita da un’opera e l’opera in sé sono cose completamente diverse. Del resto c’è chi si eccita sessualmente con Indipendence Day pur sapendo che la qualità del film lascia parecchio a desiderare. Ma andiamo avanti.
Il nuovo Re Leone è una riproposizione diretta da Jon Favreau, regista del remake de Il Libro della Giungla oltre che essere uno dei pilastri del Marvel Cinematic Universe. E il film, per forza di cose, funziona: quello che ci si trova davanti è un semplice “copia 1:1” del film originale ma interamente in computer grafica. Il lavoro svolto con la CGi è qualcosa di sbalorditivo, davvero vicino al fotorealismo con ogni piccolo particolare costruito con dovizia, facendo uso di tutte le ultime tecnologie in questo campo. Quello che colpisce sono i paesaggi degni dei migliori documentari su National Geographic, che riescono a risaltare un contesto che in fin dei conti, vede degli animali parlare. Animali semplicemente riprodotti alla perfezione… troppo. La questione “National Geographic” salta fuori quasi immediatamente: nonostante la riproposizione di alcune scene iconiche (indubbiamente suggestive), nessun passo in più sembra essere fatto dal punto di vista puramente stilistico, partendo da una fotografia (digitale) che non riesce in alcun modo a bucare lo schermo. Con la frase “ho visto documentari più belli” si riassume un po’ il tutto, con Caleb Deschanel che in nessun modo sfrutta la vastità di materiali tra luci e colori dell’Africa selvaggia capace di incorniciare una storia che in questo caso ne avrebbe assolutamente bisogno. Tutto risulta fin troppo asettico e questa asetticità la si ritrova purtroppo sui protagonisti. La ricerca della iper-realicità, benché stuzzicante, risulta essere l’autogol più grande della pellicola. Gli animali, hanno la particolarità di aver una piccolissima scelta di espressioni facciali e tranne qualche raro caso, non sono degli ottimi attori. Certo, ci sono attori che non si discostano tanto dal regno animale da questo punto di vista, ma questo abbiamo e questo ci teniamo. Sappiamo tutti quali sono le scene iconiche o qual è la scena iconica: Mufasa e la sua consapevolezza di non saper volare – lo so, è cattiva. Oltre alla mancanza di reale caratterizzazione estetica salvo qualche eccezione, la limitata espressività mozza le gambe a una storia che fa delle emozioni il suo marchio di fabbrica: nessuna espressione terrorizzata sul volto di Mufasa, nessuna trauma sul volto di Simba, nessun ghigno di Scar e soprattutto nessun volto infoiato su Nala. Se quest’ultima non inficia particolarmente sulla narrazione, tutto il resto è un puro colpo al cuore con mani a carciofo. Cosa ne viene fuori quindi? Un film essenzialmente inutile: durante la visione del film non vi è alcun motivo che giustifica questo nuovo adattamento se non il rivivere vecchie emozioni scaturite dall’originale. Ma a questo punto, perché non rivedere quello?
Anche a livello sonoro e scenografico qualcosa non quadra, con riarrangiamento delle celebri musiche di Hans Zimmer, ma che tra alti (sempre con riserva) e bassi non riescono a essere incisive. Prendiamo ad esempio “Sarò Re” di Scar: se nel classico, oltre a essere un elogio al totalitarismo, è intriso di quella teatralità che ha aiutato Scar a diventare un personaggio iconico, tra sbuffi di vapore verdastro, ombre malefiche e anche un bel plotone di iene che LVI avrebbe sicuramente apprezzato, in questa nuova versione, è semplicemente un leone decrepito che saltella tra una roccia e l’altra. Questa scena rispecchia tutto il film. Tutto è molto edulcorato e in qualche modo sin troppo “distante” per essere empatizzante come il cartone animato.
Inoltre, il cambiamento di struttura narrativa che consente un “live action”, non è stato minimamente sfruttato: l’occasione di vedere approfondita la psicologia di Scar e il rapporto dello stesso con Mufasa, gli anni vissuti da Simba in compagnia di Timon e Pumba e molto altro che avrebbe meritato una maggiore attenzione, semplicemente non esiste, come due scudetti della Juventus. Questa forse è la più grande occasione mancata, ed è strano pensarci considerando che Cenerentola, La Bella e La Bestia, Maleficent e Aladdin hanno avuto un trattamento diverso.
Sul nuovo doppiaggio, elogiando Luca Ward come Mufasa, si prosegue tra alti e bassi in cui spiccano ovviamente Marco Mengoni (Simba adulto) ed Elisa (Nala Adulta) che con le loro voci accompagnano egregiamente le canzoni iconiche del brand, facendo da tramite tra presente e passato… sino a quando le parole non ritmate entrano in scena. Non essendo un musical, si nota una certa discrepanza tra il loro doppiaggio e quello del resto del cast, nulla comunque che infici violentemente la visione.
In Conclusione
La domanda da cui bisogna partire è “ne avevamo bisogno?”. Visto il risultato la risposta sembra scontata, eppure, è molto probabile che le nuove generazioni lo adoreranno. Sarà adorato anche da coloro che vivono la loro vita un quarto di emozione alla volta, cresciuti a pane e Disney e intrisi ancora di quella magia che è facile perdere semplicemente guardandosi attorno. Viviamo in un mondo in cui il dollaro regna sovrano e questo lungometraggio possiede un “non so ché” di pericoloso: cosa vuole il pubblico? È veramente in grado di scegliere cosa guardare e di far selezione? Tutte domande senza senso per i più, ma è la consapevolezza del pubblico a decide di quale qualità vogliamo usufruire.
Il nuovo Re Leone dunque, non riesce a elevare il prodotto originale, non riesce ad approfondire personaggi e tematiche e non riesce a regalare suggestioni visive degne di nota. Sta lì, come qualcosa avvenuto dopo una sbronza ma ancora presente nei nostri ricordi, un errore, qualcosa da dimenticare ma che ormai fa parte di noi. Ci sarà un sequel? Molto probabile, ammesso e concesso che importi a qualcuno ma quei pochi, saranno comunque entusiasti come bimbi nel rivedere le avventure di Simba – Il Leone Bianco.
– Cavolo, ce l’avevo fatta a non citarlo. Proprio all’ultimo. –