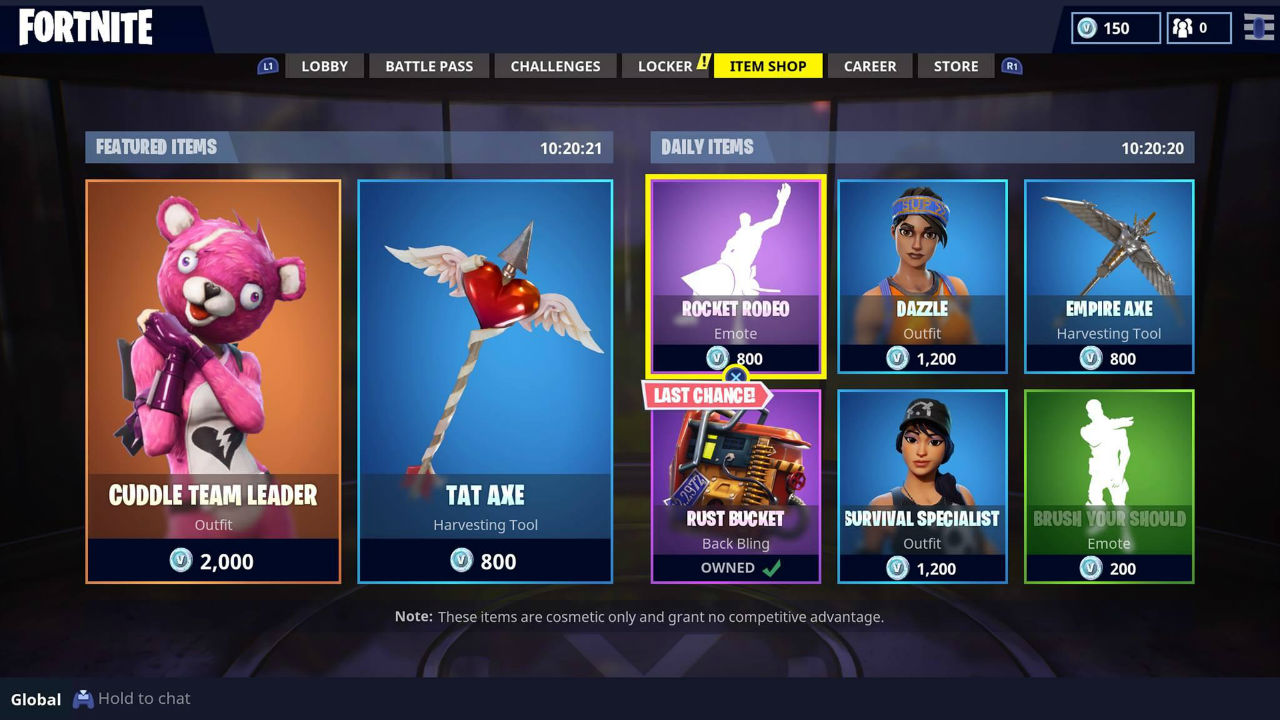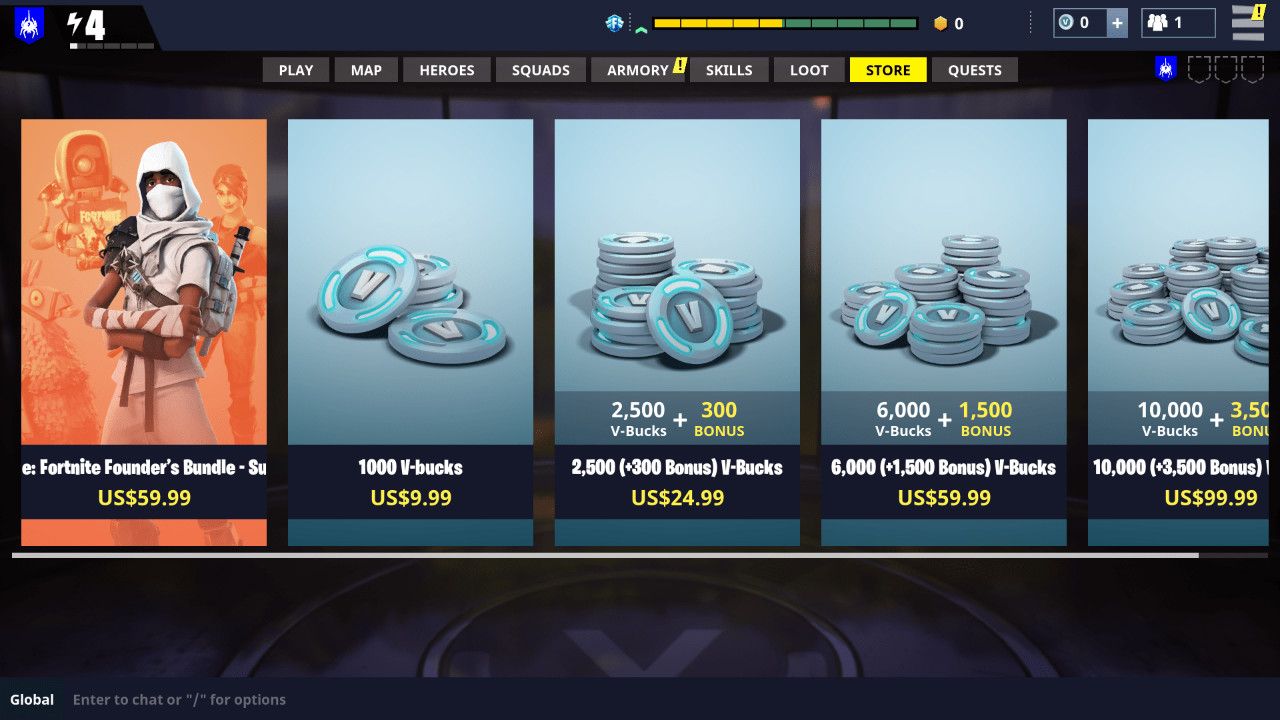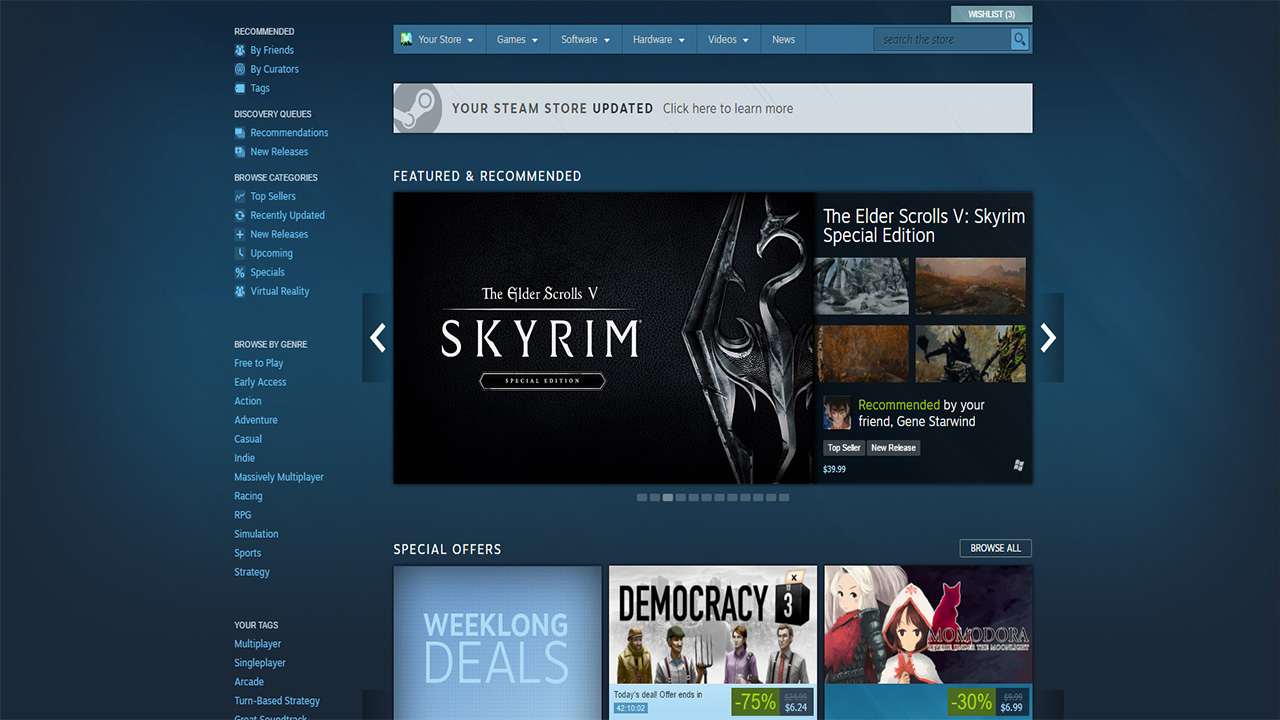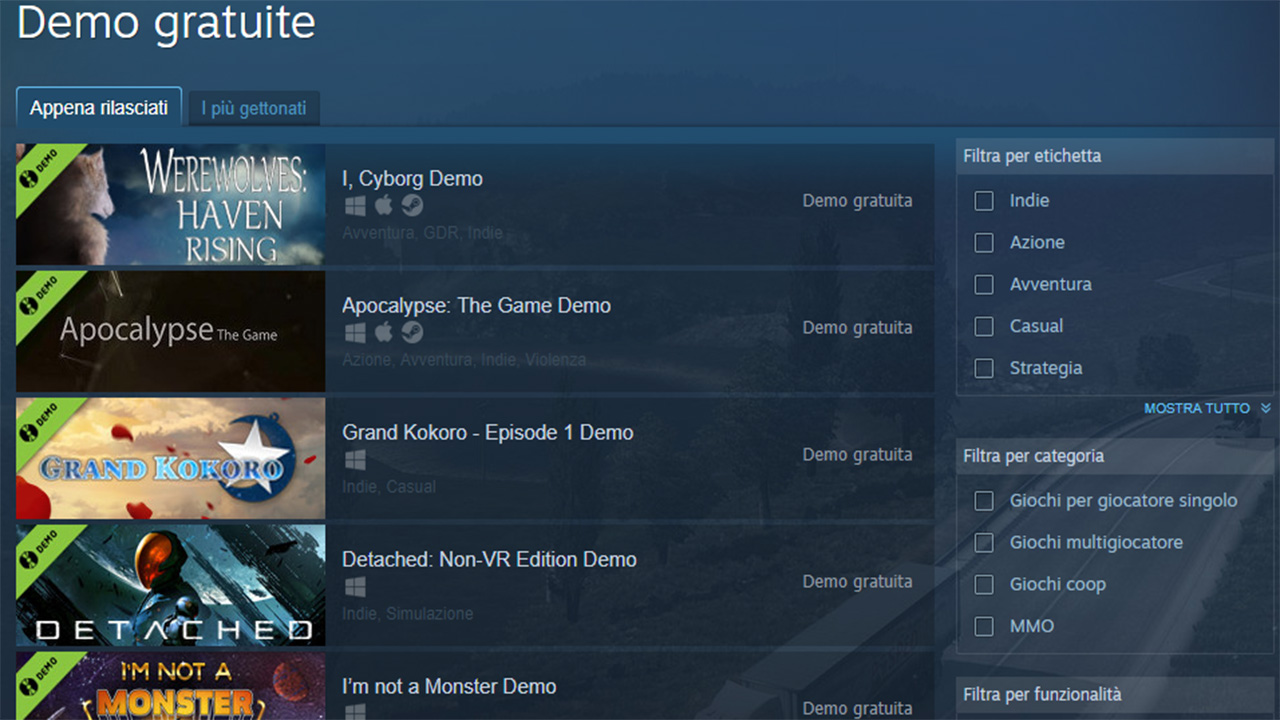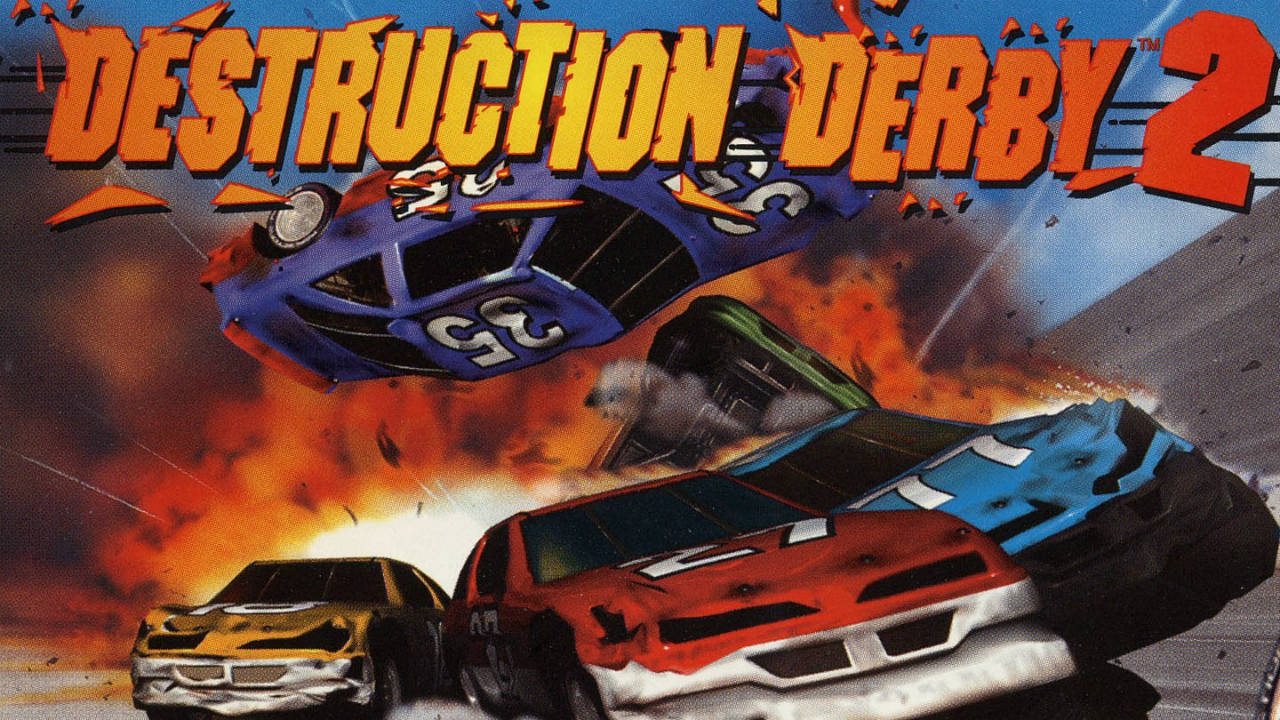Si dice che in un film noir che si rispetti non ci sono “buoni” e “cattivi” ma solamente “cattivi” e “peggiori”, personaggi che potremmo amare in un momento ma che in seguito potremmo persino arrivare a odiare. Le atmosfere dei crime drama e polizieschi noir italiani degli anni ’70, l’epoca d’oro di certi film, riprendono vita in questo nuovo top-down shooter 2D sviluppato da Italo Games; stiamo appunto parlando di Milanoir, un gioco tostissimo, dal carattere originale e dalle tematiche molto forti (tanto che in Europa ha ricevuto il PEGI 18). Tramite gli occhi del nostro protagonista, vedremo il lato oscuro della brillante Milano, nei quartieri in cui il crimine dilaga e il braccio della legge fatica ad arrivare. Il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e da poco anche su Nintendo Switch ma noi prenderemo in esame la versione per PC.

La guerra di Piero
Sin dai primi momenti il gioco ci porta in quella che è la Milano degli anni ’70: una città brulicante di vita ma che cela un animo oscuro nelle sue vie peggiori, strade in cui le piccole gang si contendono il territorio a colpi di pistola e dove pullulano Vespe Piaggio, ubriaconi e prostitute straniere. Il nostro Piero Sacchi, milanese di nascita, sa bene come vanno le cose nei quartieri bassi ma almeno è sicuro di frequentare le persone giuste, ovvero la banda del boss Nicola Lanzetta di cui è il killer numero uno e anche il braccio destro. La cosa lo riempie d’orgoglio e non c’è occasione in cui non sbatta in faccia la situazione al Torinese, il suo rivale giurato; tuttavia, una sera, le cose si mettono male per il nostro protagonista e ben presto si troverà in un guaio che lo macchierà a vita, generando in lui un forte desiderio di vendetta. Sin dai primi momenti verremo catapultati in una Milano malfamata e piena di problemi, per causarne ancora di più in nome del clan dei Lanzetta; col progredire della storia ci troveremo dunque a far fuori altri boss di quartiere, bracci destri e killer spietati ma avremo anche modo di conoscere altri misteriosi personaggi che daranno sempre più profondità alla più che profonda storia che ci viene proposta. I controlli sono più da FPS che da twin-stick shooter, al contrario di quanto ci si aspetterebbe da un gioco che propone una prospettiva bird eye; l’opzione che più si addice a questo tipo di gioco è quella di usare mouse e tastiera per muoverci in ogni direzione (limitate sempre alle otto direzioni concesse dai quattro tasti) e mirare con molta facilità mettendo il puntatore al di sopra del nemico. Col joypad ci si può muovere con più precisione ma mirare non è proprio semplicissimo. Come abbiamo detto prima, ci aspettavamo dei controlli più in linea con i twin-stick shooter ma invece abbiamo un sistema che semplicemente sostituisce il puntamento del mouse con la levetta destra del controller e ci duole dire che non è il massimo. Il mirino non torna in una posizione di default, né funziona come abbiamo visto in giochi come Tower 57 o nella versione per console di Hotline Miami; tuttavia, un sistema di controllo analogo a quest’ultimo lo troviamo durante le sezioni sui veicoli, e ci chiediamo come mai non sia stato implementato nel resto del gioco. Il controllo col joypad non è comunque totalmente debilitante in quanto è presente anche un sistema di mira automatica quando un bersaglio sarà sulla linea di tiro di Piero (e anche visibile); inutile dire che entrambi i metodi sono buoni ma, viste le scelte dei programmatori, è meglio utilizzare mouse e tastiera.
Il gameplay che ci viene proposto è tipicamente da top-down shooter, giusto con una punta di stealth e concentrato per lo più sullo storytelling e non totalmente sull’azione (o tanto meno sul realismo di quest’ultimo); dovremo superare intere orde di sgherri muniti di pistole, fucili, coltelli e quant’altro alternando in maniera più equilibrata possibile copertura e azione. Coprirsi dietro casse, muretti e quant’altro è importantissimo al fine di rimanere vivi poiché a ogni schermata potrebbe presentarsi un vero inferno e noi, con la nostra sola pistola (che nonostante le munizioni infinite dovremo sempre ricaricare manualmente), potremo non farcela. Di fronte a questi scenari possiamo appoggiarci alle armi secondarie ma, dal momento che non appaiono frequentemente, i nostri più grandi alleati saranno i cartelli stradali… Avete capito bene! È possibile che certi obiettivi non siano raggiungibili tramite un colpo diretto e andare in avanscoperta per stanarli potrebbe risultare molto rischioso; perciò, se nelle vicinanze c’è un cartello stradale, è possibile sparargli per far sì che il nostro proiettile colpisca automaticamente un obiettivo con un rimbalzo. È una meccanica che si ripete molto spesso nei livelli, è ben implementata e risulta persino varia: quelli rotondi permettono di centrare un obiettivo, quelli rettangolari due e il segnale dello stop arriva fino a sei bersagli. Lo stesso non si potrebbe dire per ciò che riguarda le armi secondarie vere e proprie, ovvero il revolver, le molotov e le granate: nulla a che vedere con la loro utilità in battaglia dal momento che funzionano a dovere e sono divertenti da usare (soprattutto il primo che permette di far fuori più nemici con un solo proiettile) ma sono generalmente pochi e poco frequenti. E parlando di povertà nel comparto delle armi secondarie ci tocca anche parlare della povertà del gameplay in generale; non fraintendeteci, ci siamo divertiti moltissimo con Milanoir, ma semplicemente è un gioco tendenzialmente statico e le sue sezioni si ripetono troppo spesso. Non che i livelli si somiglino, ma alla lunga si percepisce una forma di monotonia che potrebbe farci completare parte dei livelli un po’ controvoglia, specialmente le sezioni un po’ troppo difficili (come la boss battle contro l’Africana nel Pirellone); in ogni caso, la modalità principale è giocabile per due giocatori e può restituire un po’ di divertimento in più e magari alleggerire alcune parti snervanti. Sempre in due (o da soli) è possibile fare del nostro meglio nella modalità arena: ci ritroveremo catapultati in alcune schermate in cui i nemici arriveranno a orde e a noi toccherà farne fuori il più possibile tentando di sopravvivere più a lungo. Questa modalità è ovviamente collegata con una dashboard online che raccoglie tutti i punteggi migliori e, con un po’ di fortuna, potreste risultare fra questi (noi, al momento, siamo quindicesimi a San Vittore… Mica siamo molli noi)! Comunque, anche se il gameplay non entusiasma particolarmente, ciò che in Milanoir spicca particolarmente è senza dubbio la sua storia; il titolo ha un carattere cinematografico ben distinto ma soprattutto ben implementato, e la sua grafica pixellosa o l’assenza di doppiaggio non saranno ostacoli per godere dello splendido storytelling proposto. Anche se la sua azione è buona ma statica, la sua trama sembra sia stata scritta originariamente per essere un noir italiano degli anni ’70 e ogni scena, che sia un intermezzo o un gelido omicidio, riesce a tenerci incollati allo schermo, ci entusiasma, forse a volte ci sdegna, tanto da voler conoscere a tutti i costi il risvolto della storia; vorremo sapere fin dove Piero sia disposto a spingersi per la sua reputazione (o forse per la sua sopravvivenza), chi sono i fautori dei nostri guai o semplicemente conoscere il luogo della prossima sparatoria (visto che è sempre un piacere giocare con un titolo di cui conosciamo i luoghi). Probabilmente, l’unica cosa in più che si sarebbe potuta fare a livello di storytelling sarebbe stato immettere delle scelte di dialogo e bivi decisionali per ottenere dei finali e livelli alternativi, ma in fondo è stato meglio lasciare una trama lineare; anche se certe volte quasi ci disgusterà utilizzare Piero, questo serve a mantenere intatta la sua “brutta” personalità, a restituire a noi giocatori l’esatta visione dei programmatori dietro a questo spettacolare gioco ma soprattutto a restituire quella magia dei vecchi polizieschi. Insomma, per intenderci, gli amanti di Breaking Bad hanno amato e odiato al contempo Walter White, e questo è quel che probabilmente volevano generare gli sviluppatori nei confronti di Piero.

Gli italiani lo fanno meglio
Il gioco, realizzato col motore grafico Unity, propone una pixel-art veramente deliziosa, molto colorata ma che restituisce ugualmente quel senso di buio e sporcizia di determinate zone di Milano all’epoca del banditismo. Lo stile dei personaggi ha un che di Leisure Suit Larry, magari un tributo per rendere al meglio “quella” scena di nudo all’inizio del gioco; in relazione alla scelta stilistica, i personaggi sono ben disegnati e hanno tante caratteristiche curiose (che potranno essere notate ancora meglio osservando bene gli artwork quando prendono la parola i character). Coloro che annoverano Milano Calibro 9 fra i propri film preferiti, ispirazione fondamentale per la produzione di questo titolo, non potranno fare a meno di notare il giubbotto rosso di Piero, chiaro rimando alla figura misteriosa che seguiva il protagonista Ugo Piazza, o l’innegabile somiglianza fra Tony, il compagno di crimini del nostro protagonista, e Rocco Musco; inutile sottolineare le analogie fra le figure del boss Lanzetta e Ciro con i loro corrispettivi Vito Corleone e Alberto, interpretati da rispettivamente da Marlon Brando e Mark Margolis ne Il Padrino e Scarface. Bisogna dire che Emmanuele Tornusciolo, mente dietro la storia e dietro al game design generale, ha davvero degli ottimi gusti in termini di cinema, così come, sicuramente, il resto del team composto da Gabriele Arnaboldi (codici e direzione tecnica) e Giuseppe Longo (pixel-art e animazione). Gli scenari, in termini di bellezza, spiccano un po’ di più rispetto alle caratterizzazioni dei personaggi; nulla che risulti poco armonico, ma sicuramente gli ambienti risultano più curati, molto chiari e meno limitati in quanto a colori e a dettagli. È senza dubbio un piacere seminare il panico fra molte località famose di Milano come il Viale Monza, il Pirellone, il carcere di San Vittore, le Colonne, il Parco Lambro, il Giambellino e persino i Navigli; ovviamente le strade non sono geograficamente precise, ma tutti i tratti distintivi sono stati correttamente accentuati per restituire in tutto e per tutto le atmosfere tipiche di questi luoghi. Non sarà mai un problema, inoltre, ripararci laddove pensiamo il fuoco nemico non possa arrivare; gli elementi ambientali, come le casse, i bidoni dell’immondizia, i muretti e tutto ciò che pensiamo possa offrirci riparo, funzioneranno a dovere e questo permette un gameplay molto dinamico e intuitivo. Abbiamo trovato solamente due problematiche relative alla codifica di alcuni ambienti: nella zona del mercato ci è capitato di camminare letteralmente su un muro e raggiungere punti della schermata che dovevano rimanere inaccessibili (insomma, indossiamo un giubbotto rosso ma siamo solamente Piero, mica Peter Parker!) mentre al Duomo, durante la battaglia finale, siamo riusciti a far fuoco attraverso un muro rimanendo protetti, regalandoci praticamente un incredibile vantaggio contro il boss finale e i suoi sgherri (e ovviamente non vi diremo qual è!). Speriamo che Italo Games possa riparare presto queste piccole imperfezioni con una semplice patch.
Ad accompagnare queste belle visual c’è ovviamente una solida colonna sonora; anche qui, così come per la storia e per la grafica generale, si tenta di a larghe linee di mantenere lo stile di quelle dei film noir italiani, con un pianoforte dal sound misterioso e sfumature di flauto che rimandano, chiaramente, agli Osanna (gruppo di Progressive Rock napoletano che eseguì la colonna sonora, composta da Luis Enriquez Bacalov, del leggendario film). Bisogna ammettere che molti brani sono ben composti e riescono nell’intento iniziale, quello di farci tornare in quegli anni ’70 di fuoco, ma in alcuni brani ci sembra ci siano alcuni elementi un po’ troppo moderni (o non appartenenti a quell’epoca) che risultano un po’ fuori contesto. Magari sono false sensazioni ma, probabilmente dopo aver giocato a un’altra rievocazione di pezzi d’Italia di un altro tempo come in Wheels of Aurelia, ci aspettavamo un’operazione molto simile.

Un capolavoro mancato
Nel panorama dei videogiochi indipendenti italiani Milanoir ha un carattere fortissimo, un gioco che riesce a mostrare quel marcio che affligge nostra amata penisola senza però utilizzare stereotipi o forzature che troviamo spesso in alcuni film o, ancora più spesso, nelle fiction italiane. Lo storytelling di questo titolo è senza dubbio il punto forte, l’elemento al quale sicuramente è stato dedicato più tempo. Sfortunatamente, anche se la sua azione è molto intensa e gli ambienti molto differenziati, il suo gameplay risulta statico, dicevamo, sostanziandosi in sequenze in cui si cammina, si spara e si va in copertura: oltre c’è ben poco, sul piano della giocabilità. La meccanica dello stealth e le sezioni in movimento sono graziosamente rese ma purtroppo non riescono a dare ulteriore profondità a un gameplay che non stupisce e non rende giustizia a un’ottima trama. È vero che più avanti la nostra pistola verrà sostituita da un uzi ma ci sarebbe piaciuto poter utilizzare molte più armi, magari scegliendole da un menù, e trovare un gameplay più vario, aver magari la possibilità di interagire con NPC nel tentativo di raccogliere informazioni e oggetti, scassinare porte, poterci trovare di fronte a degli incroci e scegliere un passaggio invece di un altro; il potenziale c’era e il titolo propone meccaniche un po’ troppo semplici che, per quanto statiche, divertono comunque molto. Sarebbe però servito veramente poco per rendere il gameplay di Milanoir un po’ più vario e completare l’opera e rendere il titolo un piccolo capolavoro.
Il prezzo, sia su Steam che nel Nintendo E-Shop, non è per niente proibitivo è con poco potrete portarvi a casa un gioco che merita davvero.
Milanoir è in ogni caso un ottimo punto di partenza per Italo Games, che ci porterà certamente a tenere d’occhio i loro futuri lavori che, sfruttando il potenziale visto in questo primo titolo, potranno risultare certamente interessanti, anche al di fuori del panorama videoludico italiano.