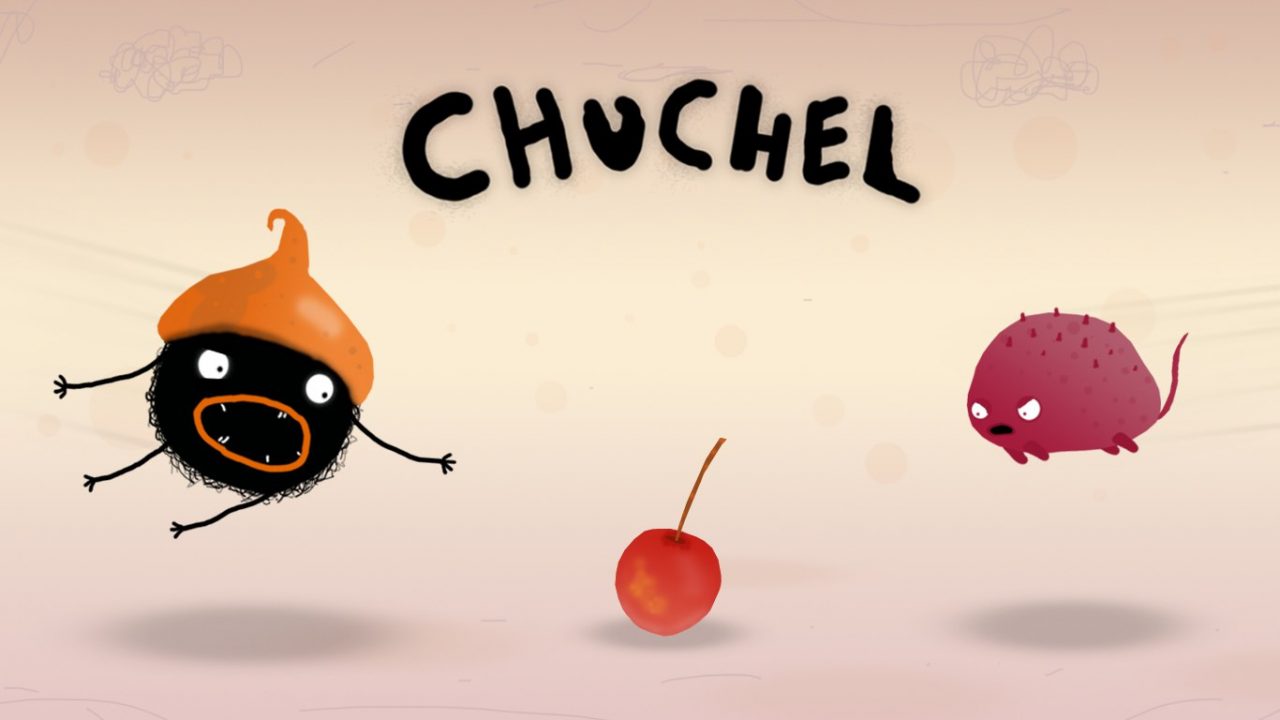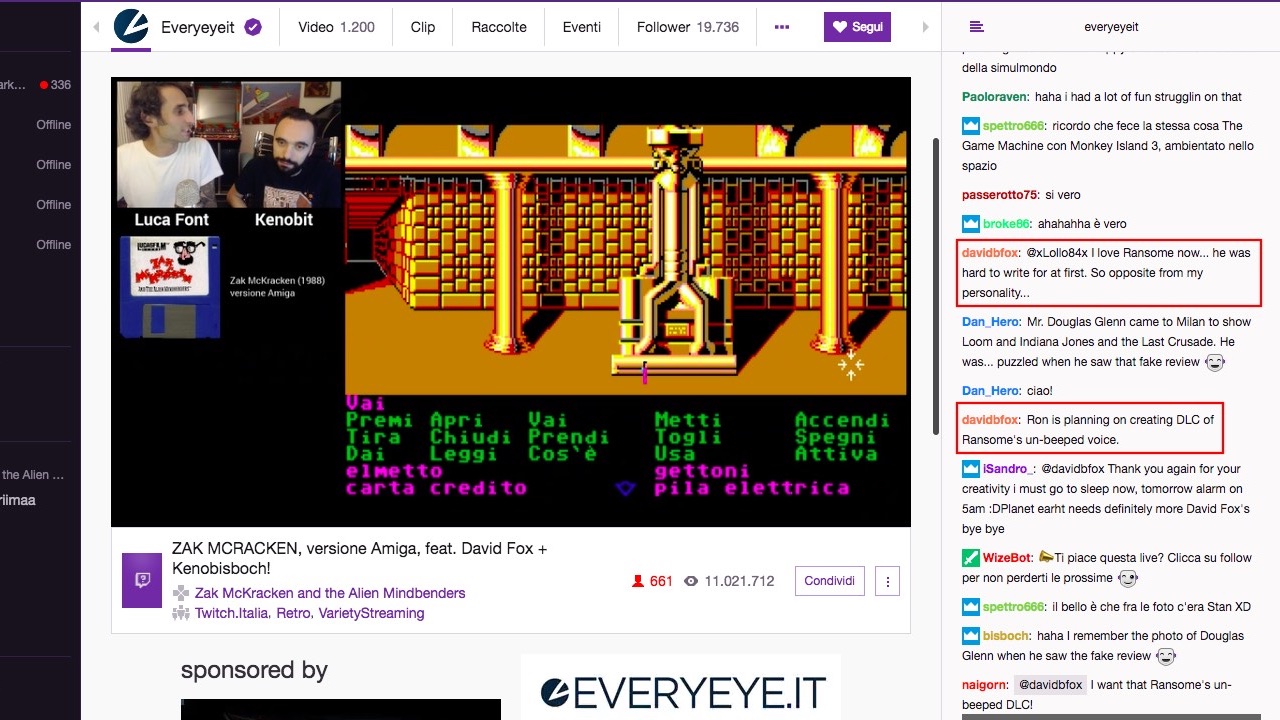Four Last Things
Prima di procedere alla lettura, si consiglia la colonna sonora che segue, partendo dal minuto 4:29:
Il videogame, orgoglioso simbolo di modernità, l’epoca del 4K, il raytracing di NVidia, la tendenza al fotorealismo, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. In Detroit: Become Human David Cage ci racconta di un 2038 in cui gli androidi acquisiscono coscienza comparabile a quella umana, Ken Levine con Bioshock ci porta in quell’Atlantide evoluta che è Rapture, dalle immagini di Cyberpunk 2077 si intravede una fine del secolo per niente rassicurante, ma avanzata sul piano tecnico: se il futuro è un paradiso di avanzamento scientifico, i videogiochi sono oggi il medium deputato a diffonderne verbo, e i developer e i game designer ne sono i cantori.
Quanto sembrerebbe anacronistico se qualcuno prendesse il Rinascimento e lo sbattesse dentro un videogame? Non intendo una riproduzione di quell’epoca, non parlo di ridisegnare per mano di mirabili e raffinati artist scenari e situazioni dell’era post-medievale, magari in versione parodistica, o al contrario cercando il realismo, o ancor di più proponendone una rappresentazione artistica personale. No, dico proprio: cosa succederebbe se un game designer pensasse di prendere dei capolavori dell’arte rinascimentale, di usarne i personaggi, gli elementi, i background, di animarli sulla scena mettendo in sottofondo le musiche del tempo, spaziando dall’opera lirica alle composizioni classiche e di farne un videogame? Pensereste che è un pazzo? Un genio? Un visionario? Un truffatore? Un profittatore, che si avvantaggia furbamente del fatto che opere vecchie di 400-500 anni non siano protette da copyright per utilizzarle a proprio piacimento?
Forse quest’ultima considerazione potrebbe essere in parte vera, ma da sola non renderebbe giustizia al lavoro dietro Four Last Things, singolare punta e clicca creato dallo scozzese Joe Richardson prendendo a piene mani il cuore del Rinascimento e intessendolo sapientemente nella tela di un software.
Di poema dignissima e d’istoria
Il concetto di “peccato” è per secoli gravato pesantissimo sugli esseri umani d’Occidente. Il Rinascimento è stato un momento chiave quando fra protestantesimo, rivoluzione copernicana, luteranesimo e rivelazioni galileane il granitico dogmatismo della fede ha cominciato a scricchiolare sotto i primi colpi dell’analisi scientifica.
La Chiesa era ancora un’istituzione forte, ma il potere spirituale cominciava a frammentarsi: in una visione parodistica, anche la giurisdizione delle anime cambia di parrocchia in parrocchia, e questo è il giusto movente per dare inizio alla bislacca storia di Four Last Things, nella quale ci ritroveremo a dover guidare il nostro personaggio attraverso i sette peccati capitali al solo scopo di ottenere la successiva redenzione. Un cortocircuito paradossale, eh? In realtà la bizzarra narrazione di Richardson ha una sua coerenza: dopo un incipit onirico nel Giardino dell’Eden, vestendo i panni di un Adamo diviso tra il giudizio severo di Dio e la tentazione di Eva, il protagonista si sveglia trafelato e in preda al panico. Roso dai sensi di colpa per i peccati commessi, corre fino alla chiesa più vicina per essere assolto ma la confessione non può essere accettata: gli atti peccaminosi sono stati commessi a Norimberga, Lubecca e Oslo, luoghi fuori dalla giurisdizione di quell’episcopato. Gli alti prelati alla porta indicano però una scappatoia: commettere nuovamente ogni peccato capitale in quel territorio permetterà al nostro di confessarsi e di poter essere perdonato retroattivamente anche per le colpe precedenti. Inizia così, con tanto di “Happy sinning”, il nostro viaggio attraverso il peccato in un’avventura unica nel suo genere: la scrittura è semplice ma ritmata, l’autore gioca in parte con un linguaggio aulico d’altri tempi ma mantiene globalmente uno stile prono, accessibile a chiunque abbia una discreta conoscenza della lingua inglese, unica opzione possibile dato che il titolo non gode di altre localizzazioni. La scrittura non sottovaluta i riferimenti all’epoca e ai suoi costumi, storpiandoli in chiave parodistica e deformandoli sotto la lente del grottesco: la scuola umoristica LucasArts emerge netta, soprattutto nei tempi scanditi in dialoghi e battute, ma anche l’influenza dei lavori dei Monty Python permea un lavoro che, pur non spiccando per originalità autoriale e brillantezza nella scrittura, riesce pienamente nell’intento mimetico, non risolvendosi in pedissequa ripetizione dei modelli di riferimento e mutuandone intelligentemente gli stilemi. È facile pensare alla Nazareth di Life of Brian mentre si cammina per una cittadina rinascimentale deformata, caotica e soprattutto popolata da personaggi bizzarri, che danno vita a dialoghi assurdi e divertenti.
Spargendo gran bellezza ardente foco
«Colui che ’l tutto fe’, fece ogni parte
e poi del tutto la più bella scelse,
per mostrar quivi le suo cose eccelse,
com’ha fatto or colla sua divin’arte.»
(Michelangelo, Rime)
Del resto, già dal punto di vista non solo umoristico, ma soprattutto visivo, è impossibile non pensare subito al gruppo comico inglese: chi abbia visto capolavori come The Meaning of Life o …And now for something completely different avrà riconosciuto i tratti di certi sketch giocati sull’assurdo, ma soprattutto il metodo d’animazione dei dipinti con cui Terry Gilliam ha fatto scuola, e che fu utilizzato per sigle e intermezzi dai Monty Python.
Ecco, i dipinti: tutto il lavoro, dicevamo, è basato su opere artistiche dell’epoca. Four Last Things è il risultato di cut-up, collage e successiva animazione di grandi quadri rinascimentali. Fra i due Pieter Bruegel (Vecchio e Giovane), Van Dyck, Van Eyck , Cranach, il Rinascimento pittorico nordeuropeo trova largo spazio, con Hieronymus Bosch a farla da padrone: apertura e chiusura hanno per scenario parti del Trittico delle Delizie, ma le opere del pittore fiammingo sono numerosissime, dalla Nave dei Folli al Concerto nell’uovo sino al Figliol Prodigo, dal quale Richardson ha addirittura preso in prestito il corpo per il protagonista, mettendogli su il volto del mercante Mathias Mulich, dipinto da Jacob van Utrecht. L’opera del visionario pittore olandese è certamente la colonna portante del gioco, e non solo sul piano visivo: lo stesso titolo, Four Last Things, fa riferimento ai Novissimi, le ultime quattro cose a cui l’uomo va incontro al termine della vita: morte, giudizio, inferno e paradiso. I Novissimi sono rappresentati nei quattro medaglioni che si trovano agli angoli dell’olio su tavola Sette Peccati Capitali dipinto dallo stesso Bosch, conservato al Prado di Madrid e qui utilizzato da Richardson per celebrare il completamento di ogni task: a ogni peccato compiuto segue un “giro di ruota”, la quale altro non è che la figura circolare al centro del dipinto dove sono raffigurati i peccati capitali. È una delle chicche di Four Last Things, che è un tripudio d’arte del XV-XVI secolo, insomma: alcuni scenari sono composti da spezzoni di opere messi assieme a formare un unico quadro, altri sono dipinti (o parti di essi) parzialmente editati, altri ancora sono frutto del lavoro di collage che dicevamo prima. Il risultato è visivamente eccellente, e non è affatto facile da ottenere, non basta avere delle opere d’arte straordinarie e bellissime per ottenere automaticamente la bellezza su schermo: il lavoro difficile sta nell’armonizzarle e far sì che l’insieme abbia un suo equilibrio. Del resto, il gioco è programmato con Visionaire Studio 4, un software acquistabile a circa 50 €, che non poteva fare particolari miracoli senza un buon utilizzo alla base.
Richardson è riuscito benissimo nell’intento di creare un punta e clicca rinascimentale sardonico e visivamente godibile, e lo ha fatto non utilizzando neanche tutto il meglio di quell’epoca storica: molti sanno che la culla del Rinascimento è l’Italia, in rappresentanza della quale non si trova alcun artista blasonato nel gioco, che annovera soltanto Francesco Melzi e Vittore Carpaccio, fra gli artisti del Belpaese.
Più spazio lo trovano i musicisti italiano, dove figurano Giovanni Cavaccio, Giovanni Palestrina e Claudio Monteverdi (trovate a inizio pagina la sua bellissima Tirsi e Clori,) e dove Richardson si è preso qualche libertà in più riguardo l’epoca, inserendo anche Vivaldi e Toscanini, musicisti che arriveranno qualche secolo dopo, ma le scelte in termini di colonna sonora risultano congrue, danno forza alle scene e contribuiscono alla creazione del contesto. E poi, diciamola tutta, potremmo mai rimproverare qualcuno per aver inserito la Gymnopédie no. 1 di Erik Satie, anche se risulta una scelta diacronica?
Il risultato audiovisivo è nel suo insieme meraviglioso.
S’ei piace, ei lice
Ideato nel 2016 durante l’Adventure Jam di GameJolt, e rilasciato nel febbraio 2018 su Steam, Four Last Things è un punta e clicca unico e ben congegnato. Nelle sue tre ore scarse di gioco non consta di enigmi particolarmente intricati, ma su un paio bisogna riconoscere una certa elaborazione a Richardson, che avrebbe voluto inserire di più nel gioco, dalla possibilità di inserire una modalità “art view”, grazie alla quale visualizzare i quadri originali, a un doppiaggio che sarebbe stato troppo oneroso per i 4178 £ (circa 4660 €) raccolti su Kickstarter. Il risultato in relazione alle risorse è ammirevole, probabilmente qualche professionalità ad affiancarlo avrebbe aiutato nel perfezionare un quest design non particolarmente intricato e avrebbe evitato qualche fastidioso bug (ogni tanto il personaggio comincia a vagare per lo schermo in maniera incontrollata, sfuggendo a ogni motion pattern predefinito e creando problemi che a volte hanno come unica soluzione il riavvio del gioco, con il rischio di perdere qualche azione, dovendo tornare all’ultimo autosave) ma, considerando che si tratta di un lavoro svolto in larga parte da unico soggetto, Four Last Things è un piccolo miracolo, pur non raggiungendo l’eccellenza. Una scrittura intelligente, un umorismo sospeso tra i Monty Python e i toni di The Secret of Monkey Island (con tanto di esplicito omaggio alla scimmia a tre teste), un’armonia visiva e sonora non comuni ne fanno un’avventura bella e piacevole da giocare e ci costringono a puntare gli occhi sul seguito, un The Procession to Calvary che per qualche giorno è ancora possibile finanziare su Kickstarter che si concentrerà molto di più sull’arte rinascimentale italiana, e che lo stesso Joe Richardson descrive come «if Monkey Island 2 had been made in 17th century Florence by a time travelling Terry Gilliam wannabe».
Non vi sembra ci siano già le premesse migliori?